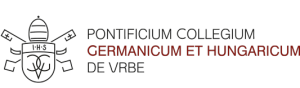Sfondo
Alla metà del XVI secolo era chiaro, agli osservatori della Curia romana, che l’avanzata della Riforma nel Sacro Romano Impero della Nazione tedesca non sarebbe stata rallentata da una riforma del clero nell’Impero stesso.
Fondazione del Collegio
In questa situazione, sotto la guida del cardinale Morone e in collaborazione con Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, papa Giulio III fu convinto a fondare a Roma un seminario per gli studenti dell’area di lingua tedesca.
Dopo essere stato legalmente istituito con la bolla papale “Dum sollicita” del 31 agosto 1552, il Collegium Germanicum fu presentato al pubblico romano il 28 ottobre 1552.
Ideali gesuiti
La gestione della casa fu affidata alla giovane Compagnia di Gesù. Ignazio stesso scrisse le prime regole per il Collegium Germanicum: diversi anni di studio scientifico, soprattutto teologico, condotta di vita religioso-morale sulla base della spiritualità religiosa dell’ordine dei gesuiti con un rigido programma giornaliero, ricezione dell’ordinazione sacerdotale, preparazione ai compiti pastorali e ritorno alla propria casa dopo gli studi.
Il Collegio e la Nobiltà
La novità di queste linee guida diventa evidente quando ci si rende conto che la chiesa imperiale tedesca, fino alla secolarizzazione del 1803, a livello dirigenziale era una chiesa dominata dalla nobiltà, in cui un breve corso di studi – spesso in diritto canonico – era sufficiente per assumere una posizione dirigenziale, l’ordinazione sacerdotale non era necessaria, e i compiti amministrativi e uno stile di vita aristocratico adatto al proprio status erano in primo piano. La storia del Collegium Germanicum è quindi segnata, fino alla fine della vecchia chiesa imperiale, anche dal tentativo di conservare il più possibile intatto l’ideale della fondazione e del fondatore nel confronto con la realtà politica della chiesa. In questo processo, l’Ordine non poté – e talvolta non volle – impedire che il Collegio in certi periodi si trasformasse in un collegio spiccatamente aristocratico, dal momento che dalla fine del XVI secolo, secondo la dichiarata volontà della Santa Sede, dovevano uscirne molti potenziali canonici e vescovi per poter garantire, con la nomina di candidati idonei, la continuità delle strutture ecclesiastiche nell’impero.
Fondazione
Il Collegium Germanicum ricevette una base finanziaria sufficiente solo nel 1573 da Papa Gregorio XIII, che trasferì al collegio vasti terreni e proprietà, con i cui proventi venivano mantenuti di solito fino a cento studenti, in modo da poter sostenere il principio religioso dell’istruzione gratuita.
Unione con il Collegio Ungarico
Nel 1580 Papa Gregorio XIII unì il Collegium Germanicum con il Collegium Hungaricum, formando il Collegium Germanicum et Hungaricum. La fusione era necessaria dal punto di vista economico e aveva senso dal punto di vista dei contenuti, poiché il Papa vedeva la Chiesa cattolica in entrambi i regni ugualmente minacciata dalla Riforma, e vedeva nella formazione dei sacerdoti come “impavidi combattenti per la fede” (formulazione tratta dalla bolla di fondazione del Germanicum) un modo per aiutare la Chiesa anche nell’area della corona ungherese.
Il Collegio in crisi
Lo scioglimento dell’ordine dei gesuiti nel 1773 non significò la fine del Collegio. L’educazione proseguì sotto la guida dei sacerdoti diocesani. Nel 1781 l’imperatore Giuseppe II, nell’ambito dei suoi provvedimenti sullo Stato-Chiesa, vietò agli studenti del suo dominio di studiare a Roma e di soggiornare presso il Collegium Germanicum et Hungaricum. Fondò invece il Germanicum et Hungaricum di Pavia con i fondi della fondazione del Collegio dell’Alta Italia. Questo collegio venne chiuso nel 1798. (Oggi l’edificio ospita il Collegio Fratelli Cairoli.) L’espulsione del clero straniero da Roma da parte delle autorità di occupazione francesi portò di fatto la vita del Collegio a Roma a un quasi arresto nel 1798.
Nuova organizzazione
Solo nel 1818 riprese gradualmente l’organizzazione per gli studi. Nel 1824, Papa Leone XII riorganizzò il Collegio come istituzione nella sua forma attuale. Caratteristica del nuovo Collegio era il suo legame ancora più stretto con la Compagnia di Gesù. Mentre prima del 1798 i cardinali, in quanto deputati del Papa, si occupavano degli affari del Collegio, ora questo compito spettava al Superiore Generale della Compagnia di Gesù. Anche dal punto di vista dello spazio, la vicinanza tra l’Ordine e il Collegio era ora maggiore di prima. Gli inizi del nuovo Collegio sono avvenuti in una casa dell’ordine con stretti legami con la comunità religiosa, e solo dal 1927 il Collegio e le istituzioni religiose sono stati separati anche dal punto di vista dello spazio.
Romanitas
L’ecclesiasticità di Stato, la lotta culturale e la legislazione antigesuita, che ponevano ostacoli allo studio a Roma fino al divieto e alla discriminazione in un successivo impiego, nonché l’orgoglio per la teologia neoscolastica della scuola romana, portarono nel XIX secolo alla massima identificazione degli studenti con il Papa e l’Ordine.
Rapporti con i paesi d’origine
Gli studenti del Collegium Germanicum et Hungaricum hanno ottenuto l’uguaglianza giuridica in Germania e in Austria solo con i concordati del XX secolo, in cui la laurea romana è stata riconosciuta dallo Stato come equivalente a un titolo di studio acquisito in un’università nazionale. Da questo momento in poi, i laureati del Collegio tornarono a fornire in numero significativo vescovi e professori universitari nel mondo di lingua tedesca, mentre nel secolo precedente erano piuttosto un’eccezione in queste funzioni.
Problemi e nuove possibilità
Con grande abilità, il Collegium Germanicum et Hungaricum è riuscito a sopravvivere alle varie turbolenze politiche dal 1870 (espropri dei beni ecclesiastici nell’Italia unita) al 1945 (agitazione comunista contro le grandi proprietà terriere), anche se la Prima Guerra Mondiale ha reso necessario il trasferimento del Collegio a Innsbruck dal 1915 al 1919 dopo l’entrata in guerra dell’Italia contro le Potenze Centrali. Una nuova fase della storia del Collegio è iniziata dopo il 1989, quando la caduta della cortina di ferro ha reso nuovamente possibile l’antica internazionalità del Collegio.
In collaborazione con Sant’Ignazio di Loyola, nell’anno 1552 il cardinale Morone riuscì a convincere Papa Giulio III a fondare un seminario maggiore a Roma per studenti di lingua tedesca. Nel 1580 lo stesso Pontefice unì il Collegium Germanicum con il Collegium Hungaricum creando il Collegium Germanicum et Hungaricum.